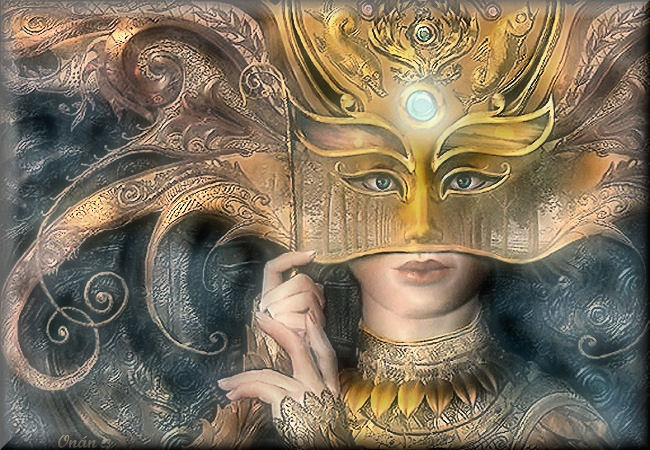|
di Paolo Scroccaro |
La quantità di saggi e commenti alle sue opere, l’ammirazione e la venerazione che fin dall’inizio gli è stata tributata, ma anche l’accanimento con cui è stato criticato, sono indici dell’importanza che Platone ha avuto ed ha ancora per il pensiero occidentale. Nella sua opera si ritrovano tutte le tematiche della filosofia: dall’etica alla politica, dalla religione all’economia, dalla medicina alla fisica, dalla psicologia all’astronomia. Questo anche grazie al fatto che il dipartimentalismo specialistico che affligge il pensiero moderno era alieno ad una mentalità secondo la quale la cultura doveva essere globale e interdisciplinare, valori che da qualche anno a questa parte si stanno riscoprendo.
Per questo motivo sbaglia chi cerca in Platone gli elementi di un pensiero dualista: questo dualismo che la nostra razionalità ci impone, si annulla ad un livello più alto, in cui gli opposti coincidono. Non a caso tutte le correnti di pensiero che si ispirarono a Platone, da Plotino a Giordano Bruno, hanno fatto della coincidentia oppositorum uno dei loro elementi essenziali.
Tutto ciò ci spinge a considerare che la ragione (diànoia) è limitata, perciò non è neppure vero che solo ciò che è razionale è reale. Si rende dunque necessario postulare una forma di conoscenza che permetta di superare i limiti della ragione; essa è per Platone l’Intuizione Intellettuale, cioè la facoltà con cui l’Intelletto (Nous) ha la visione diretta del reale; l’intelletto è l’elemento divino nell’uomo, e la sua esperienza è comunicabile solo attraverso un linguaggio che non segue le regole del pensiero razionale, un linguaggio denso, che parla attraverso immagini dai molteplici significati: il mito.
Dei miti Platone fa un largo uso, ed essi non sono né il risultato di una ragione non ancora padrona dei suoi mezzi, né lo sfogo di un tragediografo fallito, né si vogliono sostanzialmente scostare dai miti e dai simboli della religione tradizionale, che proprio attraverso questi elementi vuole portare l’uomo a comprendere se stesso, il Cosmo e gli Dei. Platone non fa che riprendere e attualizzare questo antichissimo strumento di conoscenza e di comunicazione. Certo, chi considera i miti “fiabe per bambini” non può capirne l’efficacia e sarà sempre un problema per lui capire come mai un filosofo tanto grande non si sia liberato da questa forma di conoscenza superstiziosa e grossolana. A nostro avviso il linguaggio mitico è l’unico con cui sia possibile comunicare verità altrimenti al di fuori di ogni linguaggio. Platone stesso, parlando di ciò che è oggetto dei suoi più intimi insegnamenti e della sua ricerca più profonda, afferma:
«Su ciò non esiste, né mai ci sarà, alcun mio trattato; perché questa disciplina non è assolutamente comunicabile, ma dopo molte discussioni su questi problemi e dopo una lunga convivenza, improvvisamente come luce che si accende da una scintilla, essa nasce nell’anima e nutre ormai se stessa.» (VII Lettera, 341).
Abbiamo così presentato tre caratteristiche essenziali del pensiero platonico: la coincidentia oppositorum, l’Intelletto e il mito.
Socrate, maestro di Platone, non scrisse nulla; Platone stesso denuncia più volte i limiti della scrittura come mezzo di comunicazione del sapere:
«i discorsi [si intende scritti] crederesti che parlino esprimendo un pensiero, ma se fai loro qualche domanda mosso dal desiderio di capire, annunziano soltanto una cosa, la stessa, sempre» (Fedro, 275 d).
«Gli studiosi […] trovandosi nella possibilità di essere uditori di molte cose senza impararle, acquistano la persuasione di avere numerose conoscenze, quando invece, secondo che suole accadere, sono ignoranti e di poco piacevole compagnia, diventati, come sono, portatori di opinioni invece che sapienti» (Fedro, 275b)
«Nessun uomo di senno oserà affidare i suoi pensieri filosofici ai discorsi e per di più a discorsi immobili, com’è il caso di quelli scritti con lettere» (VII Lettera, 342).
«Ogni persona seria si guarda bene dallo scrivere cose serie per non esporle alla malevolenza e alla incomprensione degli uomini. […] Quando si vedono opere scritte di qualcuno, […] si deve concludere che queste cose scritte non erano per l’autore la cosa più seria, se questi è veramente serio, e che queste cose serie riposano nella sua parte più bella; ma se veramente costui pone per iscritto ciò che è frutto delle sue riflessioni, allora “è certo che” non gli Dei, ma i mortali “gli hanno tolto il senno”» (VII Lettera, 344).
Sono considerazioni attualissime, in una cultura come la nostra, presso la quale la parola scritta ha una tale importanza che solo le culture che ne sono in possesso sono da noi considerate storiche, mentre le altre vengono frettolosamente bollate come preistoriche.
Figlio di una levatrice, Socrate diceva di aver ereditato dalla madre l’arte della maieutica, l’arte di aiutare gli uomini a generare ciò che vive in loro: la sapienza, che va amata e allevata come un essere vivente. Socrate non dà verità, non somministra le sue teorie, ma semplicemente indirizza gli uomini a ricercare, rendendoli dapprima consapevoli della loro ignoranza e poi desiderosi di sapere.
Platone, invece, scrisse, ma in una forma particolare: il dialogo. Questo strumento nelle mani di Platone, che ne è l’inventore e il più geniale utilizzatore, assume una profondità e una pregnanza che è difficile riassumere in poche righe. Il dialogo risponde infatti a numerose esigenze. Innanzi tutto la dialettica ha la funzione di portare, attraverso l’indagine tra le varie proposte ed ipotesi, al raggiungimento della verità; il presupposto è ovviamente un sincero e comune amore per la sapienza.
Attraverso il dialogo, perciò, il lettore spesso è portato a trarre conseguenze, e spesso anticipa la soluzione del problema; ben diversamente da un saggio, perciò, questa forma permette una partecipazione attiva del lettore, il quale, se non raggiungerà tuttavia il coinvolgimento di un vivo dialogo socratico, ripercorre comunque le tappe che portano alle varie conclusioni. In molti dialoghi non si arriva ad un’esplicita risposta al problema di partenza: la trovi il lettore, aiutato da tutti gli elementi raccolti e dal suo stesso desiderio di verità.
Ancora, il dialogo tenta di conservare alla parola scritta – ai cui limiti si è già accennato – la viva maieutica socratica. Nel dialogo l’autore non si trova da solo ad esporre le sue teorie, tutti i personaggi di un dialogo, con la loro cultura, con le loro esperienze e il loro pensiero, hanno importanza; perciò nel leggere un dialogo, bisognerà anche tener conto di chi sono i partecipanti: il saggio non è infatti solamente chi sa, ma chi è in grado di parlare in maniera diversa ad anime diverse, adattando il linguaggio a chi ha di fronte: egli scrive il discorso che,
«scritto con la sapienza nell’animo del discepolo, può difendere se stesso e sa parlare e tacere a proposito; […] il discorso vivo e animato di chi sa, e del quale il discorso scritto può dirsi a ragione un’immagine» (Fedro, 275e).
Se non si tiene presente tutto questo, rischia di sfuggire la ricchezza delle opere platoniche.
La vita
Platone nasce a Egina nel 427 da una famiglia aristocratica, da cui riceve un’eccellente educazione che gli suscita rispetto e interesse per la tradizione ed una notevole sensibilità per la vita politica. Verso i 18 anni incontra Socrate e ne diventa il discepolo più importante. Condivide con molti suoi coetanei una giovanile attrazione per l’attività politica, ma se ne allontanerà disgustato, dopo l’amara esperienza del governo oligarchico dei Trenta Tiranni (403-402), in cui Socrate rifiuta di essere coinvolto e che lo stesso Platone condannerà, e di fronte allo sfacelo della democrazia estremista che segue ai Tiranni e che arriverà a condannare il più giusto degli uomini – Socrate – accusandolo di corruzione dei giovani, di tradimento della città e di irreligiosità (399).
Verso il 390 inizia per Platone una serie di viaggi impegnativi, a Creta, in Egitto, a Cirene, in Magna Grecia… Platone entra così in contatto con i principali centri filosofici e sapienziali dell’antichità.
Nel 388 è per la prima volta a Siracusa, alla corte di Dionigi il Vecchio, dove tenta, con l’aiuto di Dione, di orientare il governo verso i suoi ideali filosofici. Il tentativo fallisce, e Platone viene ridotto in schiavitù: riscattato da un discepolo, rientra ad Atene e fonda l’Accademia (378), che ben presto diventa la più importante e rinomata scuola dell’Occidente.
Nel 367 Platone è nuovamente in Sicilia, a ritentare l’esperienza siracusana con il nuovo tiranno Dionigi il Giovane; ma ben presto l’intesa con il tiranno si spezza, Dione viene esiliato e solo con difficoltà Platone può rientrare ad Atene. Un altro viaggio a Siracusa, nel 361, non avrà miglior fortuna. Platone torna ad Atene, da cui non si allontanerà più. Dione tenterà di rovesciare Dionigi, ma morirà nel tentativo, con immenso dolore di Platone, che probabilmente aveva appoggiato l’impresa almeno idealmente.
Intanto gli emissari dell’Accademia svolgono un ruolo filosofico e politico importante nell’area mediterranea (si veda ad esempio l’opera dei platonici Erasto e Corisco presso il principe Ermia di Atarneo). Platone muore nel 347, lasciando un’eredità intellettuale incredibilmente vasta.
L’importanza del pensiero politico di Platone trapela anche dalla scarna biografia che ne abbiamo tracciato, ma è stata solo da poco riconosciuta dagli storici della filosofia, che spesso si accostavano ad essa con i loro preconcetti politici ed ideologici o con l’arroganza di un’epoca che si ritiene superiore a tutte le altre. Molte delle posizioni che Platone poneva alla base della sua teoria politica vengono a poco a poco riscoperte, come ad esempio il fatto, così naturale ma dimenticato per almeno due secoli, che fine della politica deve essere l’uomo e la sua realizzazione, e non l’economia.
Platone è comunque lontanissimo dall’immagine degenerata dell’intellettuale che si aliena dai problemi del suo tempo trovando un facile rifugio nei suoi libri; al contrario, fu proprio l’amara esperienza della corruzione della politica ateniese che lo convinse della necessità di un impegno attivo del filosofo nella società; come nota giustamente Voegelin, Platone
«si era reso conto, soprattutto, che –cosa che i moderni riformatori e rivoluzionari sembrano incapaci di capire– una riforma non può essere realizzata da un leader benintenzionato che tragga i propri seguaci dalle file di quegli stessi la cui confusione morale è causa del disordine politico»;
la sua opera di riformatore nasce dunque dall’individuo ed è un’opera di educazione nel senso più profondo che tale parola può assumere. Non si trattava di dare vita ad una nuova fazione politica che si affiancasse a quelle già esistenti, ma di far vivere quella che per Platone era la vera politica, di fronte alla quale la politica della sua epoca era solo una forma degenerata, quasi indegna di tale nome; Platone non esita a fare affermare a Socrate:
«Io credo di essere tra quei pochi ateniesi, per non dire il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti» (Gorgia, 521 d).
L’Accademia da lui fondata altro non fu se non una scuola per preparare filosofi-politici.
La Repubblica
È senz’altro l’opera più significativa di Platone dal punto di vista delle dottrine sociopolitiche, per la vastità delle tematiche che prende in considerazione trattando dell’esperienza politica dell’uomo. Il titolo originale, Politéia, (di cui De re publica è l’equivalente latino) è difficilmente traducibile in italiano: significa costituzione, struttura dello Stato, o meglio della Polis, che era, come si è visto, la forma di organizzazione statale della Grecia classica; il suo pregio principale, e al tempo stesso il carattere che più diversifica la vita sociale greca da quella moderna, è il fatto che essa manteneva, per le sue dimensioni, uno spiccato carattere a misura d’uomo. Non a caso il dialogo nasce attorno al problema della giustizia nella dimensione dell’individuo. Per capire che cosa sia il giusto per il singolo uomo, dice Platone, sarà bene ricercarlo dove esso si manifesta in grande scala: nella Polis. Platone afferma così il principio squisitamente greco secondo cui l’uomo è un microcosmo e lo stato non fa che rispecchiare, su vasta scala, l’organizzazione dell’essere umano: lo stato diventa il comune denominatore tra uomo, di cui è una riproduzione in grande, e cosmo, di cui è un’immagine in piccolo.
La struttura del dialogo è assai complessa e articolata; la si può paragonare a un sistema “a scatole cinesi” in cui una cornice racchiude un argomento che a sua volta viene lasciato interrotto per dare inizio ad una nuova problematica; di argomento in argomento, ci si spinge sino agli aspetti più profondi e essenziali dell’esperienza politica dell’uomo, finché si riprendono le fila di tutte le questioni lasciate in sospeso, che vengono risolte una per una, nell’ordine inverso a quello con cui si erano introdotte nel dialogo. Si crea così un’armonia nella simmetria che è degna di un uomo che non solo è grande filosofo, ma anche grande artista e scrittore.
Il cuore dell’opera è perciò la parte più preziosa, il momento culminante della dialettica che, senza lasciare nessuna questione irrisolta, si spinge fino al punto più profondo del problema della giustizia e dello Stato. E al centro della Repubblica troviamo un mito, il che ribadisce l’importanza che il linguaggio del mito riveste per la filosofia di Platone.
Il mito della caverna è uno dei più famosi di Platone, ed è una vera e propria sintesi potente della sua filosofia; esso è in stretta relazione con l’inizio e la fine del dialogo, che formano la cornice a cui si è accennato:
– Il dialogo si apre con un racconto che deve essere considerato quanto meno allegorico, perché la discesa di Socrate al Pireo, il porto di Atene, per assistere alla festa della dea Bendis, non è altro che l’allegoria di una catabasi, di una discesa agli inferi, al cuore dell’individuo e nello stesso tempo al cuore della società, rappresentato anche geograficamente dal punto più basso della città, il Pireo; l’idea è sottolineata dall’apertura del dialogo:
«Discesi (katében) ieri al Pireo…»
– La fine del dialogo è una estesa narrazione dell’esperienza fatta nel mondo degli Inferi dal guerriero Er, morto e poi ritornato alla vita: un altro mito, dunque; un’altra catabasi.
Queste tre scene scandiscono l’andamento del dialogo. Inizieremo perciò proprio con il mito della Caverna, degna introduzione non solo alla Repubblica, ma a tutta la filosofia platonica
Il mito della caverna
Repubblica, Libro VII, 514a – 517a
«– Dopo di ciò paragona la nostra natura, per quanto riguarda sapienza e ignoranza, a un fenomeno di questo genere: immagina degli uomini chiusi in una specie di dimora sotterranea a forma di caverna, avente l’ingresso aperto alla luce e ampio per tutta la lunghezza dell’antro e quivi tali uomini racchiusi sin da fanciulli, con le gambe e il collo in catene, sì da dover star fermi e guardar solo dinanzi a sé, ma incapaci per i vincoli a muovere in giro la testa; e che la luce di un fuoco arda dietro di loro, in alto e lontano, e che tra il fuoco e i prigionieri corra in alto una strada, lungo la quale è costruito un muricciolo, come quegli schermi che hanno i burattinai per nascondere le figure e sui quali esibiscono i loro spettacoli. […] Immagina ora degli uomini che lungo questo muretto trasportino oggetti d’ogni genere, sporgenti oltre il muro, e statue e altre immagini animali di pietra e di legno, e ogni sorta di oggetti; e, come è naturale, alcuni di questi portatori parlino e altri stiano in silenzio.
– Strana immagine è la tua -disse- e strani sono quei prigionieri.
– Somigliano a noi -risposi. Credi tu anzitutto che di sé stessi, e gli uni degli altri, vedano altro, fuorché le ombre riflesse dal fuoco sulla parete dell’antro di fronte a loro? […] E per gli oggetti trasportati, non è lo stesso? […] E se fossero in grado di discorrere tra loro, non pensi tu che essi prenderebbero per realtà quel che appunto vedessero? […] Quando uno di quelli che passano parlasse, credi tu che costoro riterrebbero sia altri a parlare, se non l’ombra che passa? […] Per tali persone insomma, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali.
[…] Esamina ora come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall’insensatezza. Ammetti cioè che capitasse loro naturalmente questo: qualora uno fosse sciolto e costretto d’un tratto ad alzarsi, a muovere in giro il collo, a camminare e guardare alla luce, e facendo tutto ciò provasse dolore e fosse incapace per il barbaglio di scorger gli oggetti di cui prima vedeva le ombre; cosa credi che direbbe se uno gli dicesse che prima vedeva solo vane apparenze, e che ora invece vede più giusto qualcosa di più vicino alla realtà, rivolto com’è egli a una realtà maggiore? E se mostrandogli ciascuno degli oggetti che passano, gli domandasse e lo costringesse a rispondere cosa esso sia? Non credi tu che egli resterebbe imbarazzato e riterrebbe le cose che vedeva prima più vere di quelle indicategli ora?
[…] E se quegli lo costringesse a guardare la luce stessa, non credi che gli farebbero male gli occhi, e che fuggirebbe tornando a rivolgersi a quegli oggetti di cui può sostenere la vista, e non li riterrebbe davvero più chiari di quelli mostratigli? […] E se uno lo trascinasse via a forza di lì, per l’aspra e ripida salita, e non lo lasciasse prima d’averlo tratto alla luce del sole, non credi che egli soffrirebbe e rilutterebbe a esser trascinato? E una volta giunto alla luce, con gli occhi pieni di bagliore, non credi che non sarebbe in grado di veder nulla delle cose che ora diciamo vere? […] Avrà, credo, bisogno di abituarvisi, per poter vedere gli oggetti del mondo superiore. E anzitutto discernerà più facilmente le ombre, poi le immagini umane e degli altri oggetti riflesse nell’acqua, infine gli oggetti stessi; quindi egli vedrà più facilmente i corpi celesti e il cielo stesso di notte, guardando la luce delle stelle e della luna, anziché di giorno il sole e la luce solare. […] E per ultimo egli potrà scorgere e contemplare quale è veramente il sole, e non già sue immagini nell’acqua o in altra estranea sede, ma il sole stesso nel suo proprio campo.
[…] E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che riterrebbe sé beato per il mutamento e proverebbe pietà per loro? […] Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si scambiavano allora, e ai premi riservati a chi fosse più acuto nell’osservare gli oggetti che passavano […], accetterebbe di patire di tutto piuttosto che vivere in quel modo.
[…] Se un tal uomo tornato a scender laggiù si risedesse in quella stessa sede, non avrebbe egli gli occhi pieni di tenebra, giungendo tutt’a un tratto dal sole? […] E se egli dovesse tornare a riconoscere quelle ombre, a gara con quegli altri rimasti sempre in prigionia, mentre ha ancor la vista offuscata prima che gli occhi gli si mettano a posto, e questo tempo dell’assuefarvisi non fosse brevissimo, forse che egli non farebbe ridere? E non si direbbe di lui che salito su ne torna con gli occhi rovinati e che non val neanche la pena di tentare di andar su? E chi cercasse di scioglierli e tirarli su, se essi potessero averlo nelle mani e ammazzarlo, non lo ammazzerebbero forse?»
Il significato del mito, nelle sue linee generali, è trasparente ed è spiegato dallo stesso Platone; lo si può dividere sommariamente in due parti.
– Nella prima Platone descrive ciò che intende per conoscenza e ignoranza, traccia quasi il manifesto programmatico della sua filosofia e fa probabilmente una descrizione retrospettiva del proprio cammino di conoscenza. La caverna è il mondo, le ombre sono ciò che noi, prigionieri, percepiamo con i sensi; ben diverso è il mondo delle Idee, ciò che è fuori della caverna, che è percepibile solo da chi, dopo un faticoso cammino di ricerca e di lavoro su se stesso, riesce ad accendere nel proprio intelletto la scintilla dell’intuizione.
Se però il valore del mondo delle apparenze è pari a un’ombra se messo di fronte al mondo delle Idee pure, non sarebbe tuttavia corretto ritenere che il loro valore sia per Platone totalmente negativo: le immagini sensibili sono pur sempre in una qualche relazione, se pur indiretta, con gli enti di cui sono appunto ombre. Le Idee sono cioè gli Archetipi, ovvero i modelli, gli stampi, da cui derivano gli oggetti del mondo sensibile. E il cammino che porterà a uscire dalla caverna comincia proprio dalle ombre.
Il filosofo è colui che ha portato a compimento tale cammino: il termine filosofo non indica in Platone colui che ha alle spalle lunghi anni di studio e che ha raccolto una quantità di nozioni; tali studi di per sé non garantiscono la vera Conoscenza; se essi si limitano a investigare le apparenze, senza riuscire a penetrare la radice ultima di tutto ciò che esiste -l’Uno-Bene, simboleggiato nel mito dal Sole- saranno pur sempre studi fallaci. Filosofo è piuttosto chi ha indirizzato i suoi sforzi ad una ben diversa forma di conoscenza, che è in grado di trasformare profondamente chi la consegue. La nostra corrente concezione di filosofo non sarebbe stata perciò condivisa da Platone, che la avrebbe piuttosto sostituita con il termine “philodoxos”, ovvero amante dell’opinione. Si può anzi dire, come fa Voegelin, che una corretta interpretazione della filosofia di Platone dovrebbe basarsi proprio sulla comprensione della coppia di concetti antagonisti “philosophos/philodoxos”, e che la perdita, nella lingua italiana, del secondo termine ha generato la confusione che sta alla base del fatto che veri filosofi oggi non esistono, mentre esistono molti “philodoxoi” che ne usurpano il titolo.
L’ascesa verso l’uscita dalla caverna, la quale tra l’altro come simbolo del mondo è comune alla mistica di molte culture, il risalire dal dato sensibile alla realtà “in sé” è ciò che Platone intende per educazione; come si è già accennato, Platone intendeva proporre una filosofia che fosse al tempo stesso una pedagogia, nel senso più profondo che tale parola può assumere, ovvero una scienza di trasformazione interiore. Tale educazione rappresenta la prosecuzione dell’opera iniziata da Socrate, l’arte di far generare alle anime ciò che esse portano nascosto dentro di loro. Platone fa notare che non si tratta di infondere la vista ad occhi ciechi, ma che tutti i prigionieri delle ombre ci vedono benissimo; sono semplicemente rivolti nella direzione sbagliata: l’educazione è la capacità di far volgere gli occhi dell’anima verso quelle cose che sono a lei più affini, essendo essa fatta della stessa sostanza di cui sono fatte le Idee.
– La seconda parte del mito non è meno importante, essendo di natura squisitamente politica. Il filosofo dovrà diventare politico, ridiscendere cioè dal suo mondo di essenze e di contemplazione nelle tenebre della caverna, divenute insopportabili ai suoi occhi, per riportar fuori almeno uno dei suoi vecchi compagni di prigionia. Farà ciò a gran rischio della propria vita; è indubbio che Platone alluda qui a Socrate,
«il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti» (Gorgia, 521d).
Il mito della caverna costituisce il fondamento, diciamo così, mistico della teoria politica di Platone. In questo contesto dovrebbe risultare anche più chiaro quanto si è detto sul valore della politica in Platone: quando egli affida, come si vedrà, al filosofo la guida dello Stato Ideale, intende ribadire che la principale funzione dello Stato, come lui lo intende, è di natura principalmente filosofica e spirituale, potremmo dire educativa.
In quanto è colui che ha percorso la via che va in alto, essendo il miglior conoscitore dell’idea del Bene, il filosofo assume una funzione ordinatrice di tutta la comunità sociale, in quanto è proprio lui che garantisce che lo Stato, con le sue leggi e i suoi ordinamenti, rispecchi le realtà supreme. Si fa notare per inciso che Platone fa così assumere al filosofo il ruolo simbolico che presso tutte le culture tradizionali detiene il capo della comunità: quello di centro, di asse tra umano e divino, di pontifex. Presso la stragrande maggioranza delle culture il benessere della società è conseguenza della perfetta armonia tra Terra e Cielo, garantita dal capo della comunità. Platone non fa altro che riportare un’idea di stampo tradizionale al suo orizzonte filosofico, dandole così una conformazione più vicina ai suoi tempi e ribadendone anche il significato originario.
Il filosofo diventa il garante dell’incarnazione del Giusto nella comunità statale. L’idea di Giustizia è una delle idee-guida della Repubblica, ed è anzi il primo argomento di discussione. I vari interlocutori propongono all’inizio del dialogo dei valori di giustizia che rispecchiano la crisi dei tempi di Platone: la visione aristocratica tradizionale proponeva un «far del bene agli amici e del male ai nemici», mentre la sofistica, in polemica con questa ideologia, vi opponeva una definizione del tutto utilitarista di giustizia come l’utile del più forte. Platone fa proporre a Socrate una definizione assai diversa: la giustizia è garantire a ciascuno ciò che gli spetta per natura, in opportunità di tempo e luogo. Questa definizione, all’apparenza assai generale, è in realtà di notevole importanza: il filosofo deve garantire che ogni cittadino abbia ciò che compete alla sua natura tanto a livello spirituale, quanto a livello materiale; ovvero ad ogni cittadino deve essere affidato il mestiere per cui è “tagliato”, il che è anche garanzia per lo stato di un ordinamento armonioso e pacifico, e per i cittadini di felicità e realizzazione.
I tre tipi di uomini
I compiti che i cittadini svolgono nello Stato non sono perciò esclusivamente di natura pratica e utilitaristica, ma è proprio attraverso di essi che si realizza l’educazione: il lavoro diventa una via di conoscenza. Platone indica anche una generale ripartizione delle funzioni dello Stato, che tuttavia, come dice egli stesso, è solo massimale, non tenendo conto delle infinite sfumature e differenze che esistono tra le anime di ogni uomo. Egli indica dunque tre funzioni, a cui corrispondono tre diversi tipi di anime:
– La funzione direttiva, assolta dai filosofi; la loro caratteristica è di conoscere il Bene, la loro virtù è la Saggezza. All’interno dell’organizzazione dello Stato giusto essi non possiedono beni personali, essendo tutto il loro operato rivolto al benessere della comunità.
– La funzione conservativa, affidata ai guardiani. Sono coloro che, sulla via della saggezza, sono i più simili ai filosofi nello Stato. Loro virtù è il coraggio. A loro è affidato il compito di conservare l’ordinamento corretto dello Stato, e di difenderlo contro aggressori esterni. Per il loro genere di vita Platone si è ispirato all’educazione spartana: mense, beni e abitazioni sono in comune; essi ricevono dallo Stato, per il loro servizio, di che mantenersi e di che vestirsi, ma «in misura né maggiore né minore al loro fabbisogno» (416e). Anche la loro vita è interamente dedicata alla comunità.
– Alla funzione produttiva Platone fa corrispondere un terzo tipo di anime, gli artigiani e i contadini, per i quali ammette la possibilità di un possesso personale e anche di ricchezza; dovrà pur sempre esistere tuttavia un limite massimo di ricchezza e povertà, per evitare che nello Stato qualcuno diventi talmente povero da non poter lavorare e qualcun altro talmente ricco da diventare un parassita della società. La virtù maggiore di commercianti e contadini è infatti la temperanza, il giusto mezzo, quel valore così caro ai Greci, che aborrivano chi andava oltre i limiti che erano assegnati all’essere umano, attirandosi il disprezzo degli Dei.
Richiamando Esiodo, Platone narra un “mito fenicio” sulla nascita di questi tipi di uomini (414b – 415d), e attribuisce a ciascuno di essi un metallo: oro per i filosofi, argento per i guardiani, ferro e bronzo agli agricoltori e agli artigiani. A chi chieda perché le guide dello Stato non debbano possedere oro e argento, si risponderà che «nell’anima essi hanno sempre oro e argento divino, per dono degli Dei, e che non hanno alcun bisogno di oro e argento umano» (416e). Inoltre si afferma esplicitamente la possibilità che «da oro nasca prole d’argento e da argento prole d’oro, e così reciprocamente nelle altre nascite» (415b), il che esclude che Platone intendesse dare origine a uno stato basato su un sistema di caste.
Come si vede, Platone è per certi aspetti assai attuale, e in qualche modo si può comprendere lo sproposito di chi ha riconosciuto nell’ipotesi dell’abolizione della proprietà privata una sorta di protocomunismo. Ma Platone sapeva bene che non tutti sono in grado di distaccarsi dai desideri terreni, e che anche in questo è necessaria temperanza. La sua attualità va comunque ben oltre: Platone rifiuta per il suo Stato l’esistenza di schiavi, e riconosce che la sua analisi dei tipi di uomini non fa differenza tra uomini e donne, in quanto l’anima non ha sesso. Ancora, Platone ha affermato che in uno Stato giusto non esistono leggi scritte, in quanto la stessa Giustizia che esso incarna interamente, garantisce che gli uomini siano in grado di dirimere le loro questioni e di pacificare le liti senza bisogno di fissare per iscritto le leggi, atto che, volendo dare una forma fissa e immutabile a un principio trascendente come quello di Giustizia, è destinato a fallire (Si è già parlato delle riserve che Platone aveva per la tradizione scritta).
Platone contrappone inoltre il suo modello di Stato, le cui caratteristiche sono la Giustizia, l’armonia e l’unità, a forme di governo repressive e tiranniche, che si basano su un potere del tutto arbitrario e innaturale di alcuni su altri; è paradossale che alcuni critici, più per un pregiudizio del tutto moderno che sulla base di un serio lavoro di critica, abbiano accusato proprio Platone di voler fondare uno Stato repressivo e totalitario.
Le quattro forme di governo
Dopo aver delineato nei libri V e VI gli aspetti della Polis giusta guidata dai filosofi, di cui abbiamo sopra riassunto le linee generali, e dopo aver tracciato il quadro mistico e ideale di tale Polis nel Mito della Caverna, Platone affronta, nei libri VIII e IX, il problema della degradazione di tale Polis. L’origine di tale degradazione non è ricercata da Platone in un evento storico, ma in una situazione ontologica, o per così dire mitica, per cui ogni forma di incarnazione di un’idea – e la Polis che ha delineato è appunto la forma di incarnazione dell’Idea del Bene e dell’Idea di Giustizia – porta in sé, per quanto perfetta, un principio di disgregazione, di divenire, di imperfezione. La sequenza che Platone traccia non ha perciò un carattere propriamente storico, non ha lo scopo di delineare un processo storico e non è detto che uno stato debba necessariamente passare nell’ordine attraverso le forme di degradazione che Platone traccia. Per lo stretto legame, cui abbiamo più volte accennato, che esiste tra l’uomo e la Città, ad ogni forma politica Platone fa corrispondere un carattere; ciò ha un grande valore anche dal punto di vista psicologico e sociologico, come dire che la qualità politica di uno Stato è determinata dalla maturità dei suoi cittadini, ma che per altro verso un certo tipo di stato dà vita, con la sua educazione, la sua ideologia, la sua propaganda, a un tipo corrispondente di carattere umano. Questa verità, che a noi moderni non appare così evidente dato l’abisso che separa l’individuo dalla comunità civile e politica di cui fa parte, risulta immediata in tutte le culture in cui lo Stato è di dimensione assai ridotta, come appunto era in Grecia.
– La prima forma politica è costituita dalla aristocrazia, termine cui Platone dà un valore esclusivamente etimologico, ovvero “governo dei migliori”; la chiameremo aristocrazia filosofica per distinguerla dall’aristocrazia storica . Si tratta del governo dei filosofi sopra delineato, caratterizzato dal fatto che ogni individuo svolge il ruolo che gli compete, perciò il filosofo è politico, il guardiano fa il guardiano e non possiede beni personali, il commerciante fa il commerciante e così anche il contadino. Lo Stato è caratterizzato da una forte cementazione sociale, da unità e armonia. L’opinione, oggi diffusa, che Platone abbia tracciato un’apologia dell’aristocrazia conservatrice politica ateniese in contrapposizione alla democrazia che ha seguito il governo dei trenta tiranni, nasce dal non capire che Platone intende con aristocrazia qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò che il termine oggi significa; poiché questo è chiaramente spiegato nella Repubblica e poiché Platone stesso indica chiaramente i limiti dell’aristocrazia storica del suo tempo, viene il sospetto che l’errore terminologico sia voluto. Il che indica quanto i critici moderni siano influenzati dalle loro personali convinzioni politiche.
– Il governo che si genera come corruzione dell’Aristocrazia filosofica è da Platone chiamato timocrazia, ovvero governo dell’onore (gr. timé); è caratterizzato dalla scomparsa dei filosofi, sostituiti dai guardiani, che danno vita a uno stato di tipo militare, caratterizzato in campo politico da un’alta aggressività e in campo ideologico da un’alta concezione dell’onore conquistato in battaglia, che sarà anche il principio legittimante dell’elemento al governo. L’individuo che vive in una tale società sarà arrogante e ambizioso (libro VIII, 543a – 550c).
– Ben presto i guardiani al governo inizieranno ad ac*****ulare beni personali e ricchezze, e lentamente si passerà a una costituzione di tipo oligarchico, che Platone chiama anche plutocrazia, ovvero governo basato sulle ricchezze (gr. ploùtos). Ai guardiani si sostituiranno uomini amanti del commercio e del lusso. La città apparirà opulenta e ricca, ma politicamente non sarà più un solo stato, ma due: lo stato dei ricchi e quello dei poveri, e molti componenti della società vivranno come parassiti alle spalle degli altri, senza alcuna funzione e senza produrre alcunché (libro VIII, 550c – 555b).
– Quando allora i molti poveri si accorgeranno del loro numero, rovesceranno il governo dei pochi ricchi con una rivoluzione, e daranno origine alla democrazia. Per la descrizione di questa forma di governo Platone aveva sotto gli occhi la politica del suo tempo; ma sottolineiamo il fatto che per molti tratti la democrazia greca non è assolutamente paragonabile a ciò che oggi intendiamo con tale termine. Di fatto all’interno di questa città esistono tanti stati quanti sono i suoi cittadini; essa apparirà perciò molto variopinta, poiché ogni individuo si occupa di moltissime cose, può far valere la sua opinione su ogni questione, comprese quelle di cui non ha conoscenza né esperienza. Si tratta di una situazione completamente opposta alla vita nel governo dei filosofi, nel quale ogni componente assolveva a una funzione ben precisa, che dava a lui realizzazione e alla città benessere e armonia. L’archetipo della giustizia è perciò assai lontano da questa forma di governo, e malgrado parole come medietà, giustizia, libertà siano sulla bocca di tutti, essi non sono nulla più che suoni vacui. L’uomo democratico è caratterizzato dalla mancanza di valori fondati, da un continuo oscillare tra gli estremi opposti, da un’ansia interna di nuovo e di cambiamento; si stanca subito di ciò che ha fatto e pensato ieri, la sua instabilità psicologica nasce dal fatto che, ricercando tra le ombre i valori che diano un significato al proprio esistere, muore continuamente con esse ed egli stesso non è nulla più di un’ombra (libro VIII, 555b – 562a).
– Ogni eccesso ricade nel suo opposto, e così ben presto la democrazia sfocerà nella tirannide: dal governo di tutti al governo di uno solo, che, riuscendo a assumere il potere tramite promesse demagogiche, si renderà ben presto indipendente da coloro che lo hanno appoggiato, difendendo il proprio potere con un esercito di mercenari e opprimendo il resto della popolazione. L’uomo dispotico è il contrario del filosofo: anziché ricercare l’ascesa nel mondo delle idee, e promuoverla nello Stato, il tiranno sopprimerà tutti gli individui migliori, perché costituiscono una minaccia al suo potere, ed egli stesso oltrepasserà in eccesso la confusione dei desideri in conflitto; sarà padrone di tutti i suoi miseri cittadini, ma egli stesso schiavo delle proprie passioni. Con questo Platone risponde al sofista Trasimaco, che, in apertura del dialogo, aveva affermato che il tiranno è più felice dell’uomo giusto. In realtà il tiranno vive come un prigioniero, non solo sotto la tirannia delle proprie passioni, ma nella continua minaccia di una rivolta della popolazione, di un attentato, di un colpo di stato da parte di quegli stessi che dovrebbero difenderlo. Nello stato tirannico Platone descrive una situazione diametralmente opposta all’aristocrazia filosofica, ribadendo così una volta di più la dimensione del suo pensiero politico. La tirannide può a mala pena essere considerata una forma di governo, è piuttosto una sorta di antigoverno, poiché non conserva nulla, neppure in minima parte, dell’archetipo che, per quanto imperfettamente, le altre costituzioni riproducevano. Invece di un filosofo la guida è un uomo mediocre, grande solo per le sue grandi passioni. Invece di guardiani, un esercito di mercenari vìola continuamente la giustizia compiendo soprusi. Invece di liberi commercianti e contadini che si dedicano con passione al proprio lavoro, una massa di schiavi che cade sempre più in miseria ed ha a mala pena di che sopravvivere. L’unica speranza per una siffatta costituzione è che o il tiranno diventi un filosofo, o che un filosofo si ponga a fianco del tiranno, ispirando gradualmente le sue azioni all’idea di giustizia e di bene che egli vede (libro VIII – IX, 562a – 576b).
Insistiamo nel dire che, malgrado la sequenza delle forme politiche abbia una propria logica interna, Platone non intendeva utilizzarla per descrivere necessariamente un processo storico; piuttosto si dovrà pensare che per Platone l’eventuale valore storico della sequenza ha origine nel fatto che la storia stessa non è che il riflesso e l’incarnazione di una struttura mitica o archetipica.