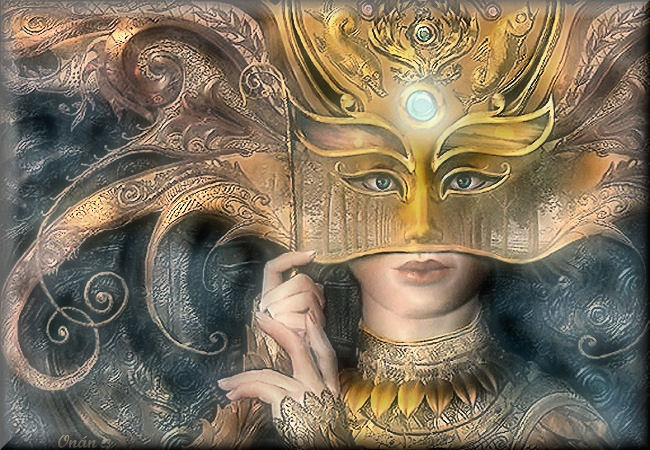La nozione del Sanâtana Dharma è una di quelle che non hanno in Occidente un equivalente esatto, al punto che appare impossibile trovare un termine o un’espressione che ne renda il significato in modo completo e in tutte le accezioni; qualsiasi traduzione che di essa si potrebbe proporre risulterebbe, se non interamente falsa, per lo meno molto inadeguata. Ananda K. Coomaraswamy pensava che l’espressione che poteva forse, alla meno peggio, fornirne un sostituto approssimativo era quella di Philosophia Perennis, intesa al modo del medio evo; se ciò è vero sotto certi aspetti, tuttavia tra le due nozioni esistono differenze notevoli, che è tanto più utile esaminare in quanto certuni sembrano troppo facilmente credere alla possibilità di una loro pura e semplice assimilazione.
In primo luogo dobbiamo osservare che la difficoltà non verte sulla traduzione del termine sanâtana, di cui il latino perennis è effettivamente un equivalente; in questo caso si tratta propriamente di «perennità» o di perpetuità, e non affatto di eternità come talvolta si dice. Il termine sanâtana comporta infatti un’idea di durata, mentre al contrario l’eternità è essenzialmente la «non-durata»; la durata di cui si tratta è indefinita, se si vuole, o più precisamente «ciclica», nell’accezione del greco aiônios, il quale pure non ha assolutamente il senso di «eterno» che i moderni, per una deplorevole confusione, troppo sovente gli attribuiscono. Perpetuo, in questo senso, è ciò che persiste in modo continuo dall’inizio alla fine di un ciclo; e secondo la tradizione indù il ciclo a cui la nozione di Sanâtana Dharma dev’essere riferita è un Manvantara, ovvero la durata di manifestazione di una umanità terrestre. Aggiungeremo subito, e più avanti si vedrà tutta l’importanza di questa, osservazione, che sanâtana ha pure il senso di «primordiale»: d’altra parte è facile comprendere il rapporto diretto che lega questo nuovo significato col precedente, giacché non può essere veramente perpetuo se non ciò che risale all’origine stessa del ciclo. Infine, occorre che sia ben chiaro che simile perpetuità, con la stabilità che le è necessariamente connessa, pur se non deve venir confusa con l’eternità, con la quale non ha anzi neppure possibilità di raffronto, è tuttavia quasi un riflesso, nelle condizioni del nostro mondo, dell’eternità e dell’immutabilità che sono proprie di quei principi di cui il Sanâtana Dharma è l’espressione nei suoi confronti.
La parola perennis, in sé, può anche contenere tutti i significati che abbiamo illustrato; ma sarebbe piuttosto difficile indagare fino a qual punto gli scolastici del medio evo, al linguaggio dei quali appartiene in proprio il termine Philosophia Perennis, ne fossero chiaramente coscienti, perché il loro modo di considerare le cose, pur essendo evidentemente tradizionale, non si applicava che a una sfera esteriore e perciò soggetta a molteplici limitazioni. A ogni modo, e pur ammettendo che si possa, indipendentemente da ogni considerazione di carattere storico, restituire a questa parola il suo pieno significato, resterebbe sempre il fatto che a richiedere le riserve più gravi quanto all’assimilazione di cui stavamo parlando, è l’impiego del termine Philosophia, il quale corrisponde in certo qual modo proprio alla natura della limitazione del punto di vista scolastico. Innanzi tutto, e tenuto conto principalmente dell’uso che di essa fanno abitualmente i moderni, questa parola può troppo facilmente prestarsi ad equivoci; questi potrebbero in realtà dissiparsi se si avesse cura di precisare che la Philosophia Perennis non è affatto «una» filosofia, vale a dire una concezione particolare, più o meno ristretta e sistematica, frutto di questo o quell’autore, ma il fondamento comune dal quale derivano tutte le filosofie in ciò che hanno di realmente valido; e questo modo di considerarla corrisponderebbe di fatto al pensiero degli scolastici. Soltanto che anche in tal caso permarrebbe una improprietà, poiché la realtà di cui stiamo parlando, quando venga considerata come una autentica espressione della verità, come di fatto deve, sarebbe ben più Sophia che non Philosophia; la «saggezza» non deve essere confusa con l’aspirazione che tende ad essa o con la ricerca che ad essa può condurre, e secondo la sua stessa etimologia la parola «filosofia» designa propriamente soltanto queste due cose. Si dirà forse che essa è suscettibile di una certa trasposizione, e anche se non ci pare che ciò si imponga come forse avverrebbe qualora non si avesse a disposizione nessun termine veramente migliore, non è nostra intenzione contestarne la possibilità; ma pur nel caso più favorevole, questo termine sarà sempre ben lontano dal poter venire accettato come un equivalente di Dharma, perché non potrà mai designare se non una dottrina la quale, per esteso che sia il campo da essa abbracciato, rimarrà in ogni caso soltanto teorica e non corrisponderà di conseguenza a tutto ciò che comprende il punto di vista tradizionale nella sua integralità. Secondo quest’ultimo infatti, la dottrina non è mai intesa come una semplice teoria sufficiente a se stessa, ma come una conoscenza da realizzarsi di fatto, e dalla quale, per di più, discendono delle applicazioni che si estendono a tutte le modalità della vita umana senza eccezione.
Tale estensione può essere dedotta dallo stesso significato della parola Dharma, significato che d’altronde non può venir reso interamente nelle lingue occidentali da un unico termine: in conseguenza della sua radice dhri, che ha il senso di portare, sopportare, sostenere, mantenere, questa parola designa innanzi tutto un principio di conservazione degli esseri, perciò un principio di stabilità, almeno per quanto quest’ultima sia compatibile con le condizioni della manifestazione. È importante rilevare che la radice dhri è quasi identica, nella forma e nel significato, a un’altra radice, dhru, da cui proviene la parola dhruva, la quale designa il «polo»; ed è effettivamente all’idea di «polo», o di «asse» del mondo manifestato che ci si deve riferire se si vuol capire la nozione di Dharma nel suo senso più profondo: si tratta di ciò che permane invariato al centro delle rivoluzioni di tutte le cose, e regola il corso del divenire proprio in quanto non vi prende parte. A questo proposito bisogna tener conto che il linguaggio, a causa del carattere sintetico del pensiero che esprime, è qui molto più strettamente legato al simbolismo di quanto non sia nelle lingue moderne, nelle quali un legame del genere, e in misura ristretta, persiste solamente più in grazia di una lontana derivazione; così che si potrebbe forse anche far vedere, se non ci portasse troppo fuori del nostro argomento, come la nozione del Dharma si ricolleghi piuttosto direttamente alla rappresentazione simbolica dell’«asse» per mezzo della figura dell’«Albero del mondo».
Si potrebbe dire che il Dharma, a considerarlo in modo assoluto, è necessariamente sanâtana, e perfino in un’accezione più estesa di quella che abbiamo indicato prima, perché, invece di contenersi a un determinato ciclo e agli esseri che in esso si manifestano, si applica in ugual modo a tutti gli esseri e a ogni stato di manifestazione. Si ritrova così l’idea di permanenza e di stabilità; ma è assiomatico che questa idea, in mancanza della quale non si può d’altronde parlare di Dharma, può venire applicata, in modo relativo, a livelli differenti e in campi più o meno ristretti, e proprio da ciò sono giustificate tutte le accezioni secondarie o «specifiche» a cui si presta questa parola. Proprio perché deve essere concepito come principio di conservazione degli esseri, il Dharma risiede per essi nella conformità alla propria natura essenziale; si può perciò parlare, in tal senso, del dharma proprio di ciascun essere, chiamato più precisamente swadharma, o di ciascuna categoria di esseri, come si può parlare del dharma di un mondo o d’uno stato di esistenza, o soltanto di una determinata porzione di questo, e del dharma di un certo popolo o d’un certo periodo; quando si parla di Sanâtana Dharma si tratterà, come abbiamo detto, dell’insieme di una umanità e per la durata di tutta la sua manifestazione, la quale costituisce un Manvantara. In questo caso si può anche dire che si tratta della «legge» o della «norma» propria di tale cielo, formulata fin dall’origine dal Manu che la governa, vale a dire dall’Intelligenza cosmica che in essa riflette la Volontà divina ed esprime l’Ordine universale; in linea di principio è questo il senso vero del Mânava-Dharma, senza tener conto di tutti gli adattamenti che da esso potranno aver origine e che d’altra parte riceveranno legittimamente la stessa designazione perché ne saranno, tutto sommato, come altrettante traduzioni richieste da questa o quella circostanza di tempo e di luogo. Bisogna tuttavia aggiungere che può accadere che, usata in un caso come questo, l’idea di «legge» suggerisca di fatto un certo senso di restrizione, giacché, anche se essa può, come succede per il suo equivalente ebraico Thorah, essere applicata per estensione al contenuto di tutto l’insieme delle Scritture sacre, ciò a cui fa pensare in modo più immediato è naturalmente l’aspetto «legislativo» propriamente detto, il quale è certamente lungi dal costituire tutta la tradizione, benché ne sia parte integrante in ogni civiltà che può essere detta normale. Questo aspetto è in realtà una semplice applicazione al campo sociale, applicazione che però, come tutte le altre, presuppone di necessità la dottrina puramente metafisica che è la parte essenziale e fondamentale della tradizione, e la conoscenza principiale da cui tutto il resto dipende in tutto e per tutto, e senza la quale nulla di veramente tradizionale, in qualsivoglia ambito, può assolutamente esistere.
Abbiamo parlato dell’Ordine universale che, nella manifestazione, è l’espressione della Volontà divina e riveste in ogni stato d’esistenza modalità particolari, determinate dalle condizioni proprie di questo stato; il Dharma potrebbe, per lo meno sotto un certo riguardo, venir definito come conformità all’ordine, e ciò spiega la stretta parentela che lega questa nozione con quella di rita, che è anch’essa l’ordine e ha etimologicamente il senso di «rettitudine», come il Te della tradizione estremo-orientale, con cui il Dharma indù ha più d’un rapporto, ciò che ricorda evidentemente ancora l’idea di «asse», l’idea cioè di una direzione costante e invariabile. Nello stesso tempo il termine rita è chiaramente identico alla parola «rito», e quest’ultima, nella sua accezione primitiva, designa infatti anch’essa tutto quel che è compiuto conformemente all’ordine; in una civiltà integralmente tradizionale, e a maggior ragione all’origine, ogni cosa ha un carattere propriamente rituale. Il rito viene ad assumere un’accezione più ristretta in seguito al processo degenerativo che porta alla nascita di una attività «profana», e ciò in qualsiasi campo; ogni distinzione tra «sacro» e «profano» implica infatti che certe cose siano ormai riguardate da un angolo visuale diverso da quello tradizionale, mentre prima questo s’applicava in ugual modo a esse tutte, e le cose che vengono in tal modo viste come «profane» sono per questa ragione stessa diventate adharma o anrita. È importante comprendere che se il rito, il quale corrisponde perciò al «sacro», conserva sempre lo stesso carattere «dharmico», se è lecito esprimersi in questo modo, e si presenta come ciò che è rimasto qual era prima della degenerazione, è l’attività non rituale a essere veramente deviata o anormale. In particolare, tutto ciò che è soltanto «convenzione» o «costume», senza ragione profonda e d’istituzione puramente umana, in origine non esisteva, ed è esclusivamente il prodotto di una deviazione; il rito, inteso tradizionalmente ‑ come dev’essere per meritare questo nome ‑ non ha, contrariamente a quel che pensano certuni, nessun rapporto con queste cose, che al massimo possono esserne una contraffazione o una parodia. Per di più, e anche questo è un punto essenziale, quando parliamo qui di conformità all’ordine, non è da intendere l’ordine umano soltanto, ma ben di più e principalmente, l’ordine cosmico; infatti in ogni concezione tradizionale vi è sempre una stretta corrispondenza tra l’uno e l’altro, ed è precisamente il rito che mantiene in modo cosciente le relazioni tra i due, in quanto implica in qualche modo una collaborazione dell’uomo, nella sfera in cui si esercita la sua attività, all’ordine cosmico stesso.
Conseguenza di ciò è che se il Sanâtana Dharma è concepito come tradizione integrale, esso comprende in modo principiale tutte le branche dell’attività umana, le quali d’altronde vengono proprio perciò «trasformate», giacché grazie a questa integrazione esse partecipano del carattere «non umano» che è proprio di ogni tradizione o che, meglio ancora, forma l’essenza stessa della tradizione in quanto tale. Si tratta perciò esattamente del contrario dell’«umanesimo», il quale è il modo di considerare le cose che pretende di ridurle a un livello esclusivamente umano e in fondo fa tutt’uno con il punto di vista profano: è in questo particolarmente che la concezione tradizionale delle scienze e delle arti si differenzia profondamente dalla loro concezione profana, e in misura tale da poter dire, senza esagerazione, che ne è separata da un vero e proprio abisso. Secondo la prospettiva tradizionale ogni scienza e ogni arte non sono realmente valide e legittime se non in quanto ricollegate al principi universali, talché le scienze e le arti si presentano in definitiva come un’applicazione della dottrina fondamentale in un determinato ordine contingente, così come, in un campo diverso, un’altra applicazione sono la legislazione e l’organizzazione sociale. Grazie a questa partecipazione all’essenza della tradizione, scienza e arte possiedono in ogni loro modo di operazione quel carattere rituale del quale abbiamo detto in precedenza e che non è assente da nessuna attività finché questa rimanga quel che deve normalmente essere; aggiungeremo che non è da fare, secondo questo modo di vedere le cose, nessuna distinzione fra le arti e i mestieri che, nella tradizione, sono esattamente la stessa cosa. Non è il caso che ci dilunghiamo ora su queste considerazioni, che sono già state da noi esposte e sviluppate in altre occasioni; pensiamo però di aver detto abbastanza perché si possa apprezzare quanto tutto ciò vada, e sotto ogni riguardo, oltre la «filosofia» in qualunque modo la si intenda.
Dovrebbe essere facile adesso capire cosa sia in realtà il Sanâtana Dharma; esso non è nient’altro che la Tradizione primordiale, che sola permane in continuazione e senza cambiamenti per tutta la durata del Manvantara e così possiede la perpetuità ciclica, dalla sua primordialità stessa essendo sottratta alle vicissitudini delle epoche successive, sì che sola può dirsi, rigorosamente parlando, veramente e pienamente integrale. Questa Tradizione primordiale è in tutti i casi, in conseguenza della marcia discendente del ciclo e dell’oscuramento spirituale che ne consegue, diventata nascosta e inaccessibile all’umanità ordinaria; essa è la fonte prima e il fondo comune di tutte le forme tradizionali particolari, che da essa procedono per adattamento alle condizioni speciali di questo o quel popolo, in questa o quell’altra epoca; ma nessuna di queste forme potrebbe identificarsi con il Sanâtana Dharma vero e proprio o esserne considerata l’espressione adeguata, pur se ne è evidentemente quasi un’immagine più o meno velata. Ogni tradizione ortodossa è un riflesso e, si potrebbe dire, un «sostituto» della Tradizione primordiale in tutta la misura che permettono le circostanze contingenti; se anche non è di fatto il Sanâtana Dharma, tuttavia una tradizione ortodossa lo rappresenta veramente per coloro che vi aderiscono e effettivamente vi partecipano, perché è soltanto attraverso a essa che costoro possono pervenire a raggiungerlo; ed è essa che del Sanâtana Dharma esprime, se non la totalità, per lo meno tutto ciò che li riguarda direttamente e nella forma più appropriata alla loro natura individuale. In un certo senso tutte le diverse forme tradizionali sono, nel Sanâtana Dharma, contenute in modo principiale, poiché esse ne sono altrettanti adattamenti regolari e legittimi, e persino gli sviluppi di cui sono suscettibili nel corso del tempo non possono essere anch’essi che un adattamento di questo tipo; ma secondo un’altra maniera di vedere, in certo qual modo inversa e complementare della precedente, esse tutte contengono il Sanâtana Dharma come ciò che è in esse di più interiore e «centrale», tenuto conto che, nel loro diversi gradi d’esteriorità, esse sono simili a veli che lo ricoprono e non lo lasciano trasparire se non in modo attenuato e più o meno parziale.
Siccome ciò è vero di tutte le forme tradizionali, sarebbe un errore voler assimilare in modo puro e semplice il Sanâtana Dharma a una di esse, qualunque essa sia, per esempio alla tradizione indù quale si presenta a noi attualmente; se di fatto questo errore viene talvolta commesso, non sarà che da parte di coloro il cui orizzonte mentale, per le condizioni in cui si trovano, è esclusivamente limitato a quest’unica tradizione. Se anche tale assimilazione è in certa misura legittima, secondo quanto abbiamo appena spiegato, è allora vero che gli aderenti di ognuna delle altre tradizioni potrebbero dire anch’essi che, nello stesso senso e per le stesse ragioni, la loro propria tradizione è il Sanâtana Dharma; in senso relativo questa affermazione sarebbe ancora vera pur essendo in senso assoluto evidentemente falsa. E tuttavia v’è una ragione grazie alla quale la nozione del Sanâtana Dharma appare legata più particolarmente alla tradizione indù: ed è che codesta è, di tutte le forme tradizionali viventi al presente, quella che più direttamente deriva dalla Tradizione primordiale, sicché si presenta in qualche modo come la sua continuazione all’esterno, pur dovendo tener conto, naturalmente, delle condizioni in cui il ciclo umano si svolge; di questo svolgimento essa dà d’altronde una descrizione più completa di quante si potrebbero trovare altrove, mentre partecipa in grado più alto di tutte le altre tradizioni alla perpetuità della Tradizione primordiale. Inoltre, vale la pena di notare che la tradizione indù e la tradizione islamica sono le sole ad affermare esplicitamente la validità di tutte le altre tradizioni ortodosse; e la spiegazione di questo fatto risiede in ciò che, essendo esse la prima e l’ultima in ordine di tempo nel corso del Manvantara, devono l’una e l’altra integrare, sia pure in modi diversi, tutte le diverse forme che sono apparse nell’intervallo, per rendere possibile il «ritorno alle origini» con cui la fine del ciclo dovrà ritrovare il suo inizio e che, al punto di partenza di un altro Manvantara, manifesterà nuovamente all’esterno il vero Sanâtana Dharma.
Ci restano da segnalare due concezioni sbagliate che sono purtroppo molto diffuse alla nostra epoca e che sono l’indizio di una incomprensione certamente ben più grave e completa che non sia l’assimilazione del Sanâtana Dharma a una forma tradizionale particolare. Una di queste concezioni è quella dei cosiddetti «riformatori», quali si incontrano oggidì persino in India, i quali credono di poter ritrovare il Sanâtana Dharma attraverso una sorta di semplificazione più o meno arbitraria della tradizione la quale in realtà non corrisponde che alle loro proprie tendenze individuali, e quasi sempre non fa che rivelare certi pregiudizi provocati dall’influenza dello spirito moderno e occidentale. È il caso di notare che quel che siffatti «riformatori» si accaniscono a voler eliminare prima di tutto, è generalmente ciò che ha il significato più profondo, e questo accade sia perché tale significato sfugge loro interamente, sia perché si oppone irrimediabilmente alle loro idee preconcette; tale atteggiamento è abbastanza simile a quello dei «critici» che respingono come «interpolazioni» tutto quel che in un testo non si accordi con l’idea che se ne sono fatta o col senso che vorrebbero trovarci. Quando noi parliamo di «ritorno al principi», come abbiamo fatto prima, si tratta in realtà di tutt’altra cosa, che non dipende d’altronde nemmeno dall’iniziativa degli individui in quanto tali; e certo non si vede perché la Tradizione primordiale dovrebbe essere semplice come pretende questa gente, se non a motivo di ciò che, per infermità o debolezza intellettuale, ci si augura che così sia; e perché poi la verità dovrebbe essere obbligata a adattarsi alla mediocrità delle facoltà di comprensione dell’uomo medio attuale? Basta, per rendersi conto che non è affatto così, capire, da una parte che il Sanâtana Dharma contiene tutto quanto è espresso attraverso tutte le forme tradizionali, senza eccezione, e con qualcosa in più; dall’altra, che sono necessariamente le verità d’ordine più elevato e profondo a essersi fatte più inaccessibili in conseguenza dell’oscuramento spirituale e intellettuale che accompagna la discesa del ciclo; stando così le cose, la semplicità cara ai modernisti, di qualunque genere essi siano, è dunque lungi, e il più possibile, dal costituire un segno rivelatore dell’antichità d’una dottrina tradizionale, e a maggior ragione della sua primordialità.
L’altra concezione errata su cui intendiamo richiamare l’attenzione è soprattutto tipica delle scuole contemporanee che si ricollegano a quel che si è convenuto di designare col nome di «occultismo»: il procedimento di queste ultime è generalmente un «sincretismo» che accosta le diverse tradizioni, nella misura in cui può conoscerle, in modo tutto esteriore e superficiale, e nemmeno per tentare di dedurre quanto esse contengono di comune, ma esclusivamente per raffazzonare alla meglio e disordinatamente qualche elemento preso a prestito dall’una e dall’altra; il risultato di queste costruzioni, che non si sa se siano più eterogenee o fantasiose, è poi presentato come l’espressione d’una «saggezza antica» o di una «dottrina arcaica» dalla quale sarebbero nate tutte le tradizioni e che dovrebbe perciò identificarsi con la Tradizione primordiale ovvero col Sanâtana Dharma, anche se tali termini sembrano essere quasi sconosciuti alle scuole di cui parliamo. È assiomatico che tutto ciò, per quanto possano esserne ambiziose le pretese, non può avere il minimo valore e corrisponde a un modo di vedere esclusivamente profano, tanto più che le concezioni di questo genere si accompagnano quasi invariabilmente al disconoscimento più assoluto della necessità, per chiunque voglia penetrare a un grado qualunque nel dominio della spiritualità, di aderire prima d’ogni altra cosa a una tradizione determinata; e sia ben inteso che noi vogliamo parlare di una adesione effettiva, con tutte le conseguenze che essa implica, compresa la pratica dei riti di tale tradizione, e non semplicemente di una vaga simpatia «ideale» come quella che spinge certi Occidentali a dichiararsi indù o buddhisti senza saper bene di cosa si tratti e in ogni modo senza nemmeno pensare a ottenere un ricollegamento reale e regolare a queste tradizioni. E tuttavia è proprio questo il punto di partenza al quale nessuno può sottrarsi, e soltanto dopo ognuno potrà, a misura delle sue capacità, cercare di andar più lontano; infatti non è di speculazioni campate in aria che discorriamo, ma di una conoscenza che deve essere essenzialmente tesa all’ottenimento di una realizzazione spirituale. È soltanto in questo modo infatti, dall’interno delle tradizioni, o potremmo dire più esattamente ancora. dal loro stesso centro ‑ se si riesce a giungervi ‑ che si può prendere realmente coscienza di quel che fa la loro unità essenziale e fondamentale, e di conseguenza ottenere veramente la piena conoscenza del Sanâtana Dharma.
Studio apparso nel libro Approches de l’Inde (Les Cahiers du Sud, 1949), raccolta di testi e articoli pubblicati a cura di Jacques Masui. [N.d.T.]
in Studi sull’Induismo